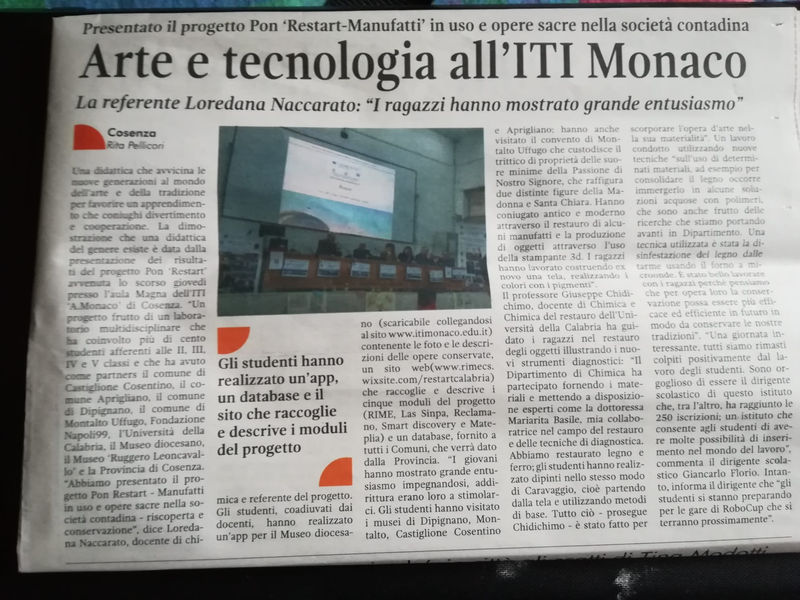"Differenze di abitudini e linguaggi non contano se i nostri intenti sono identici e i nostri cuori aperti"
J.K.Rowling

Ritrovata memoria
La scienza sostiene il nostro passato
.jpeg)

Making the past live again
Reperimento e classificazione materica degli antichi manufatti


Una App per la scoperta del museo Diocesano di Cosenza
Biografia Restart
Progetto: RESTART - Manufatti in uso e opere sacre nella società contadina: riscoperta e conservazione.
Descrizione progetto e realizzazione
Fino alla metà degli anni 50’ la vita delle comunità calabresi era largamente improntata su un
modello di tipo rurale. Le popolazioni che abitavano in piccoli comuni arroccati il più delle volte
su impervi territori, vivevano principalmente di agricoltura, pesca, pastorizia. Il settore terziario
era scarsamente rappresentato da qualche impiegato comunale, un medico, un farmacista e da
pochi altri notabili. La vita veniva scandita dal lavoro nei campi e da quelli casalinghi nei quali
sia gli uomini, quanto le donne, davano prova della loro creatività e fattibilità, in attività nelle
quali impiegavano utensili e manufatti semplici ma essenziali ed efficienti, il cui uso si era
consolidato nei secoli.
Periodicamente occorreva fare il pane, prelevando la farina da cassettoni bassi e lunghi con
coperchi a volte ribaltabili (cascioni) che servivano anche come base di appoggio per sostenere
apposite vasche in legno (le mattre) usate per impastare. Le donne e qualche volta anche gli
uomini impastavano a forze di braccia, affondando ritmicamente i pugni chiusi nella pasta che
gradualmente diventava omogenea ed elastica al punto giusto. Il pane prendeva forma sotto le
agili e forti mani delle massaie, che poi veniva cotto nei forni a legno. Anche per questa
operazione occorrevano vari manufatti, generalmente in legno: pale per inserire e levare il pane
dal forno, rastelli per distribuire il fuoco durante la fase di riscaldamento del forno, scovoli per
raffreddare alla giusta temperatura la superficie inferiore del forno se troppo calda etc.
Poi era il tempo dell’uccisione del maiale in inverno: grande festa per tutte le famiglie
contadine! Le vasche per l’impastatura della farina si trasformavano in raccoglitori della carne,
finemente spezzettata con coltelli, previamente affilati dagli arrotini ambulanti o dagli uomini di
casa per mezzo di pietre abrasive raccolte sui greti dei torrenti. Salsicce, soppressate, capicolli
e prosciutti prendevano gradualmente forma in almeno due intense giornate di lavoro, scelte
accuratamente per avere nell’ambiente di casa l’aria secca adatta alla cura dei salami.
L’uccisione del maiale richiedeva il possesso di grandi pentoloni (le cuadare) per bollire
l’acqua necessaria ad ammorbidire le setole e renderle rasabili con coltelli affilati e per
trasformare il lardo in strutto con una lunga e lenta cottura. Non potevano mancare i treppiedi in
ferro, fatti dal fabbro del paese o comperati alle fiere, per sostenere “le cuadare” sul fuoco
acceso negli ampi focolari.
Ma prima ancora della lavorazione dei maiali, in autunno si vendemmiava. Quasi tutte le
famiglie possedevano una vigna più o meno grande. A settembre le uve raccolte venivano
pestate con i piedi dentro grandi tini, conservati nelle cantine (i catuoi) di casa e poi spremute
nei torchi di legno, dopodiché’ i mosti messi a bollire nelle botti.
Naturalmente per tutto il periodo dell’anno occorreva prendersi cura delle coltivazioni negli
appezzamenti di terra che tutti possedevano, tranne i più poveri che lavoravano come braccianti
presso i grandi possidenti. A novembre occorreva arare i campi con aratri trainati da buoi,
tradizione ormai millenari. Non tutti possedevano un aratro e una coppia di buoi, e li chiedevano
in prestito a coloro che avevano gli animali e l’attrezzatura necessaria. Quasi mai queste
prestazioni venivano pagate con soldi, ma era in uso l’arte del baratto, che spesso consisteva
nello scambio di giornate lavorative: tu mi ari i campi, io vengo ad aiutarti a seminare o a
raccogliere le olive, a vendemmiare.
Tra gli attrezzi più comuni che si ritrovavano nelle case dei contadini più facoltosi vi erano
sicuramente i finimenti per i buoi e tutte gli attrezzi per l’aratura. A volte gli aratri erano fatti in
legno con una punta di ferro. I buoi per l’aratura in coppia erano uniti da speciali collari ai quali
si attaccava anche l’aratro. Nelle case dei contadini non mancavano mai gli arnesi per
dissodare e appianare i terreni: pale, picconi, zappe di varie fogge e varie dimensioni. Servivano
a zappare le vigne, preparare i terreni per la semina, piantare gli orti. Speciale cura veniva
anche posta nella potatura degli alberi e nella costituzione della riserva di legna per l’inverno.
Perciò tra gli attrezzi facevano bella mostra di sé asce di foggia di diverse dimensioni a seconda delle necessità e degli usi richiesti.
In definitiva ogni casa era come una piccola fabbrica che serviva a produrre tutto il necessario
per sfamare la famiglia. Una fabbrica dove tutti occupavano un posto preciso nella necessaria
distribuzione del lavoro e dove la buona volontà, la fantasia, il saper fare di ciascuno si
cimentava nel compito di produrre quanto fosse necessario alla vita e alla sopravvivenza di tutti
i membri della famiglia. Questo era il modo di vivere di gente che alla fatica del lavoro, spesso
duro, abbinava però un alto livello di socialità, un modo più naturale di vivere e forse di essere
felici. Questa società contadina era anche fortemente legata alle tradizioni cattoliche e
frequentava le numerosissime chiese presenti nei paesi o nelle proprie contrade, anche come
momento di socializzazione e di arricchimento della propria interiorità. Addirittura in alcuni
paesini della provincia era presente una chiesa per quartiere. Molti contadini erano analfabeti e
attraverso i quadri a esempio, apprendevano i contenuti della bibbia raccontata dai parroci. Un
tempo era diffuso l'uso da parte della Chiesa di commissionare molte opere sacre, che
arricchivano le diocesi e inorgoglivano gli abitanti.
Intorno al 1950 nelle campagne Calabresi durante il tempo della mietitura incominciò a
comparire una specie di mostro: la trebbiatrice meccanica. L’uso di questa macchina veniva a
sostituire il vecchio metodo di separare i chicchi di grano delle spighe che consisteva nel far
calpestare le fascine di grano mietuto da una pietra piatta trainata, al di sopra delle fascine di
grano, lungo cerchi concentrici da una coppia di buoi. A questa operazione seguiva
l’allontanamento della paglia per ventilazione naturale, alzandola con appositi forconi e
lasciando che il vento la accumulasse lontano dai cumuli di chicchi grano che venivano
allontanati mano a mano che si evidenziavano sull’aia. La trebbiatrice aveva un lungo collo
terminante con una testa dentellata, che si abbassava ciclicamente per trascinare i fasci di
grano nel suo ventre dove, appositi rulli li battevano, separando la paglia dai chicchi che
venivano automaticamente insaccati. Cominciarono anche a comparire i primi trattori per arare
la terra che venivano soprattutto utilizzati per terreni non molto scoscesi e di grandi dimensioni.
Tutte queste macchine per i bambini erano un’attrazione importante, anche se l’odore di nafta
bruciata dava qualche fastidiosa sensazione, nell’aria calda dell’estate. Con la comparsa della
trebbiatrice e dei primi trattori, il mondo antico cominciò rapidamente a sparire, e ben poco ne
sarebbe rimasto soltanto dopo una ventina d’anni. Ovviamente la trasformazione
dell’agricoltura ancestrale in una agricoltura moderna portò molti vantaggi, ma anche alla
scomparsa di una società che si basava su consuetudini millenarie. Con essa sparì anche il
mondo della solidarietà contadina. Non era più necessario che le famiglie si unissero per
lavorare a turno nei poderi di ciascuno. I rapporti di amicizia e solidarietà si allentarono
gradualmente, a favore di una progressiva crescita dell’individualismo e della logica del profitto.
Spariva gradualmente una cultura, della quale forse oggi cominciamo a sentire nostalgia. Vi era
più fatica umana, ma anche una solidarietà sociale calda ed efficace.
Con il passare del tempo i paesi si spopolano, dalle campagne della provincia cosentina si
registra un esodo verso le città, o in altre regioni e purtroppo anche fuori Italia e si accentua il
triste fenomeno dell’emigrazione. Molte delle opere d’arte presenti nelle chiese abbandonate o
poco frequentate sono trafugate o rovinate dall’incuria dell’uomo. Per proteggere quindi quelle
rimaste, sono state portate dai parroci di tutta la provincia di Cosenza ai Vescovi che si sono
succeduti e che per molto tempo le hanno conservate nei loro palazzi dell’Arcidiocesi. Per
valorizzarle e conservarle è stato realizzato il giovanissimo Museo Diocesano di Cosenza,
costruito da soli 4 anni, ma contenente opere importantissime, quali a esempio “la Bibbia dei
poveri” ovvero il bellissimo quadro del famosissimo pittore Luca Giordano proveniente da un
Convento dei Cappuccini di Cosenza ormai chiuso, oppure le splendide statuette in avorio
michelangiolesche, o il polittico di Borgo Partenope, le Via Crucis su cui anche il critico d’arte
Vittorio Sgarbi in visita al museo si è soffermato, riconoscendone subito l’autore Jacopo da
Bassano. L'opera più importante, però, rimane la Stauroteca già adottata dagli studenti
dell’I.T.I. “A. Monaco” di Cosenza nel Concorso Nazionale 'Adotta un monumento della Nostra
Italia e studiata sotto i più svariati aspetti, storico artistico, chimico per le analisi strumentali sugli
smalti della croce, tecnologico e multimediale, conquistando nel 2016 la medaglia d'oro, unica in
Calabria su 700 scuole d'Italia.
Il progetto in esame parte dalla considerazione che il contadino di un tempo era anche un
artigiano consapevole dell’idea che il suo manufatto, oltre che funzionale era esteticamente
piacevole. Ed anche se i canoni del bello ai quali si ispirava non erano raffinati, tuttavia tocca e
commuove scorgere qua e là negli strumenti destinati alla cucina, alla stalla o al lavoro dei
campi, la fioritura di un intaglio, di un intreccio, di un intarsio, di una ribattitura che di questi
oggetti rendono più amabile l’uso. Attraverso gli oggetti eposti si può così leggere, oltre i
sistemi di vita che hanno caratterizzato la civiltà contadina per centinaia e centinaia di anni
prima dell’avvento dell’automazione, un timido e geloso desiderio di bello a dispetto delle
difficili ed aspre condizioni di sopravvivenza. Gli oggetti ci parlano così di un mondo che si può
dire, abbia cessato di esistere dopo l’ultima guerra mondiale: ed è proprio in questa ottica di
recupero, valorizzazione e trasmissione di questa importante eredità culturale che il seguente
progetto, affondando le sue radici in un insieme di tradizioni qualificanti, restituisce dignità e
interesse ad un mondo ricco di valori e tradizioni.
Il progetto RESTART vuole riportare all’attenzione delle giovani generazione quel mondo e
quella cultura che rischiano di essere dimenticati, focalizzando l’attenzione sui manufatti del
tempo e sul modo di conservarli e all’occorrenza restaurarli. Dall’osservazione e dallo studio
dei meccanismi delle antiche macchine e dei motori utilizzati in agricoltura si sono proposti
modelli moderni con rappresentazioni in 3D, utilizzando le tecnologie di ultima generazione, per
rispondere anche alla richiesta del mercato di saper rappresentare con il tridimensionale. In un
articolato lavoro pluridisciplinare, dove si è dato rilievo all’approfondimento delle materie
d’indirizzo per il triennio, si sono potenziato l’italiano, la matematica(quest'ultima come materia trasversale), ma molte altre materie fondamentali alla realizzazione del progetto;
chimica, disegno, inglese, informatica e meccanica. Sono stati recuperati e raccolti alcuni
manufatti tipici della vita domestica e della vita lavorativa, vecchi di almeno 70 anni, attraverso il
coinvolgimento delle famiglie degli allievi che diventeranno, insieme ai loro figli, i protagonisti di
quest’avventura.
Si è adottato un bene artistico di inestimabile valore: un trittico a Montalto Uffugo che si sta
deteriorando per le condizioni ambientali in cui riversa, sensibilizzando i responsabili a
sistemarlo in un luogo più idoneo e salvandolo da una” fine annunciata”.
Si sono utilizzati i laboratori della scuola per fornire competenze per restauri
anche di oggetti casalinghi e per trovare i giusti rimedi al loro degrado, per educare gli
allievi ad apprezzare il valore di un oggetto restaurato e quanto sia importante averne cura
per il patrimonio artistico del territorio nonché per valorizzare i beni di famiglia, che
molte volte vengono dimenticati o addirittura abbandonati.
L'attività di laboratorio si è intrecciata con l'attività di progetto, culminando con la realizzazione
delle attrezzature usate in passato dagli artigiani e contadini riproducendoli con le stampanti 3D
di cui è ampiamente dotato l'Istituto. Ciò è diventa una occasione significativa per aiutare gli
studenti a misurarsi con le competenze raggiunte.
Si è aggiornato il patrimonio culturale, artistico religioso di Montalto Uffugo e in particolare del museo di Leoncavallo, opere sacre di Aprigliano, opere sacre di Castiglione Cosentino, Museo del rame e degli antichi mestieri di Dipignano, la Nave della Sila, realizzando un data base” intelligente.
Attraverso visite guidate nei paesi che collaborano al nostro progetto, gli allievi a diretto contatto
con gli antichi manufatti e le opere d’arte, hanno sviluppato la dimensione sensoriale attraverso la
vista, il tatto, l’udito, per accrescere anche le competenze linguistiche. . Inoltre,
a Rose è stato progettato e proposto un un museo diffuso che si snoda per il centro storico e collega i punti essenziali del borgo: edifici monumentali ed architettura minore legata alle tradizioni. Importante è stato il coinvolgimento fattivo degli abitanti dell'area presso i quali sono state acquisite notizie di
vario genere (sociali, economiche, artigianali, ecc.).
E’ stata inoltre, in continuità con i lavori già effettuati nel Museo Diocesano, rafforzata l’opera
d’informatizzazione con i mezzi multimediali, per accrescere l’interesse
dei visitatori e favorire l’attività turistica nell’intero comprensorio, ma anche all'estero, con la realizzazione di un’app. La“realtà virtuale” accresce la pubblicizzazione e la conoscenza delle opere d’arte, gradita sicuramente agli emigrati della nostra Terra in Paesi lontani, felici di condividere i
nostri, che sono anche i loro tesori nei quali possano ritrovare le loro radici. Museo e scuola
offrono un significativo apporto per far sì che il patrimonio possa essere costantemente
ricreato e ricostruito nei significati, accogliendo interpretazioni provenienti da diverse culture,
educando alla tolleranza e all’accoglienza, nella società multietnica e multiculturale.
Si è scelto di lavorare attraverso la cultura con attività laboratoriali e applicazioni tecnologiche, come fattore aggregante per la ricomposizione di squilibri sociali,
educando gli studenti alla cultura della cittadinanza attiva e responsabile.
I laboratori scientifici tecnologici hanno consentito, a
studenti e docenti, di approfondire la storia locale, acquisendo procedure e metodologie
d’indagine storica, artistica e tecnologica, per avvicinarsi a un’opera d’arte in modo critico,
leggendola con chiavi differenti.
Ampio spazio è stato dato alle visite in loco nei paesi partner, dove gli allievi hanno
osservato i manufatti contadini e gli attrezzi conservati nelle stanze dei comuni o nei loro musei,
studiandone la composizione chimica e lo stato di conservazione, la loro funzione, la loro storia,
fotografandoli e facendo un report. Tutte le informazioni acquisite sono poi state interscambiate tra i
vari moduli.
Altri eventi
Abbiamo visitato anche Montalto e Rose, le loro bellezze
A Montalto, Abbiamo individuato in particolare un’opera Poco valorizzato e dimenticate : splendido trittico di proprietà delle Suore Minime della Passione di Nostro Signore, adottato in questo progetto. Suor Emma, ovvero Teresa Bibiani con il permesso della Superiore Suor Paola il cui nome anagrafico è Rosaria Pennisi ci ha accpagnati a visionarlo. Lo spettacolo iniziale è stato scoraggiante. L’’opera era allocata in una chiesa dismessa con scale fatiscenti e soffitti cadenti. ma, tra polvere e calcinacci ci è apparsa in tutta la sua bellezza questo meraviglioso trittico, raffigurante due distinte figure della Madonna e Santa Chiara, segnati dall’usura del tempo e delle condizioni atmosferiche.
Oggi le suore sono state costrette a togliere le tele dalla loro splendida cornice e trasportarle nel loro istituto, il solo modo che avevano per proteggerle.
la dott.ssa Pamela Ferraro,poi, a Montalto Uffugo ci ha ben accolto con grande professionalità nel comune, facendoci visitare e scoprire il museo di Ruggero Leoncavallo.
Altra bellissima esperienza è stata per noi visitare il Comune di Castiglione Cosentino. Accolti da Sindaco onorevole Salvatore Magaro, che ha organizzato in modo impeccabile le visite nelle botteghe artigiane e in particolare nell'officina dei fabbri……….. Ci hanno mostrato la lavorazione del ferro, con l'incudine, il martello e il fuoco, come una volta. Tutto rigorosamente a mano. Di contro ci hanno mostrato anche i modernissimi infissi in alluminio che rendono che ha l'abitazione di classe energetica A. E poi dei loro modelli di panchine che diventano all'occorrenza tavoli. Un'esperienza toccante, come quella nella chiesa dei santi Nicolò e Biagio restaurata dopo anni difficili, con delle colonne imponenti, presenta dei veri e propri tesori, che don Salvatore Buccieri ci ha mostrato con dovizia di particolari che abbiamo riportato sul nostro data base. Consigliamo di visitarla.
Nel modulo reclamami ”(Reperimento e classificazione materica antichi manufatti), abbiamo visitato il museo del Rame e degli Antichi Mestieri” di Tessano e la “filanda, antichi mestieri, falegnameria” a Dipignano che vantano con una raccolta di più di diecimila pezzi e con centinaia di visitatori all'anno. Ad accoglierli due professionali guide che hanno spiegato con minuzia di particolari e il dott. Guglielmo Guzzo che ha accolto la scolaresca con molto entusiasmo.. “è stato bellissimo vedere dal vivo i lavori che si svolgevano una volta. A Tessano abbiamo visto la rappresentazione della lavorazione dell'uva per ricavare il vino, il mulino trainato dal mulo gli aratri per coltivare i terreni come quello a "votasacco", tutti gli strumenti del farmacista, del calzolaio, del sarto, del barbiere, del cestaio fabbro e l'esposizione di varie trappole per gli animali, finanche l'angolo del maiale.). Nell'area di Dipignano l'allestimento che mi ha colpito di più è stato quello dei "Quadarari" perchè è proprio da Dipignano che nasce il Girovagare dei "Quadarari. In questo museo abbiamo vissuto un viaggio nelle nostre Origini, la nostra Storia. Le foto sono dell’alunno Jason
Altra tappa, del nostro percorso, è stata la visita al Museo degli antichi mestieri e al Comune di Rose. Lì il nuovo sindaco, Roberto Barbieri, alla presenza Salvatore Liguori assessore alle politiche agricole e forestazione, ci ha accolto illustrandoci gli scavi archeologici e la famosissima statuetta Kore. Nella e nel museo degli antichi mestieri, poi, accompagnati dalla dott.ssa Giulietta Coscarelli, abbiamo approfondito gli oggetti che si utilizzavano una volta, tra cui il telaio, molto antico, col quale le mamme trssevano il corredo per le figlie, e altri oggetti quali il rastrello, a sula, u crivu (cestino che serviva per trasportare il grano), u timpagnu, u stricaturu per lavare i panni a mano e a quadara nella quale si cucinava la carne di maiale, in particolare i frittuli.